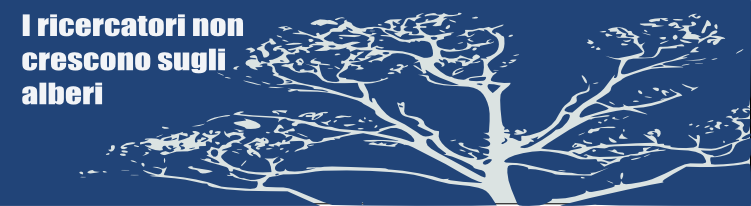Pochi giorni fa l’Organizzazione per la cooperazione economica e lo sviluppo (Ocse) ha pubblicato il rapporto
Education at a Glance 2011, che presenta una documentata analisi statistica dell’istruzione dei principali paesi del mondo.
Giuseppe de Nicolao ne ha discusso i punti salienti, per quanto riguarda l’università e la ricerca. Ad esempio, in Italia ci sono
pochissimi laureati rispetto alla media Ocse (posizione 34 su 36 nazioni). Questo non tanto per inefficienza, quanto perché l’investimento in istruzione avanzata è molto scarso: la spesa cumulativa media per studente è inferiore al 75% della media Ocse mentre la spesa in percentuale al Pil ci vede
quartultimi su 34 nazioni.
La quantità della spesa è dunque un aspetto rilevante del problema che va considerato in tanti ambiti, a cominciare dall’obiettivo di aumentare il numero di laureati garantendo seriamente il diritto allo studio. Per semplificare possiamo immaginare due modelli antitetici per reperire le risorse. Nel primo, essenzialmente quello attuale in Italia come nella maggior parte dei paesi europei, l’istruzione e la ricerca sono pubbliche e finanziate dalla
fiscalità generale più dalle tasse universitarie. Entrambe queste tassazioni (circa 80% e 20% del totale della spese) sono basate su aliquote progressive con il reddito.
Nel secondo modello si parte dal presupposto che lo Stato è inefficiente ed
il sistema non è riformabile: mentre
il mercato crea ricchezza, lo Stato è parassita. Riversando il
costo dell’università direttamente sugli utenti (le famiglie) si dovrebbero innescare dei meccanismi di mercato che farebbero aumentare vorticosamente e magicamente la qualità del sistema universitario. Per questi motivi, seguendo la recente esperienza inglese, bisognerebbe consentire agli atenei di
aumentare le tasse universitarie per tutti gli studenti
anticipando
, a carico dello Stato, il costo sostenuto dagli studenti meno abbienti per frequentare l’università. Bisognerebbe consentire poi, agli studenti beneficiati del prestito, di ripagare il debito in futuro, ma solo se
e quando raggiungeranno un reddito sufficientemente elevato
Mentre in Inghilterra c’è stato un furioso dibattito sull’introduzione di questo modello da parte del governo Cameron, in Italia c’è chi utilizza ogni occasione possibile per
riproporre questa soluzione, o varianti di questa (vedi ad esempio
qui). Questa tesi viene giustificata dal fatto che è necessario evitare che “
i poveri finanzino la laurea ai ricchi” come adesso avverebbe in quanto i poveri vanno poco all’università. Dunque, anche se a prima vista non sembrerebbe, visto che di colpo, a parità di fiscalità generale, le tasse universitarie aumenterebbero di un fattore 5/10 (o anche più), questa soluzione viene presentata come un modello a vantaggio dei “poveri”: si tratterebbe dunque di una
proposta di sinistra tanto che si
cerca di convincere il Pd a farla propria.
Gli argomenti usati fanno tuttavia acqua da tutte le parti.
Ad esempio, poiché le aliquote, dirette ed indirette, sono progressive con il reddito non è vero
che nel sistema attuale i “poveri” pagano l’università ai “ricchi”: se ci fosse uno sbilanciamento in questo senso (cosa da dimostrare) sarebbe comunque sufficiente abbassare relativamente le aliquote dei ceti meno abbienti rispetto a quelle dei ceti più abbienti per riequilibrare la situazione. Il meccanismo più
ideologico e denso di potenzialità distruttive di questa proposta è legato alla restituzione del debito: se lo studente trova un buon lavoro restituisce i soldi allo Stato, altrimenti è
l’ateneo che deve restituirli. In questo modo gli atenei si vedono costretti ad agire come imprese private:
investono sulla possibilità che i propri studenti trovino lavori ben remunerati.
Diventa così il mercato del lavoro a influenzare cosa s’insegna e, minimizzando il rischio
, si è naturalmente portati a concedere prestiti a studenti provenienti da famiglie più abbienti che studiano materie più vicine al mondo delle professioni; analogamente, l’accorto investitore-studente sceglierà gli studi potenzialmente più remunerativi. Si presuppone, dunque, che l’istruzione sia un
investimento personale finalizzato all’incremento del reddito a vantaggio del singolo e non della collettività e che il
valore sociale di un’attività lavorativa venga misurato dal reddito che se ne ricava e non anche, o sopratutto, dall’utilità sociale di questa: è più utile socialmente un
promoter finanziario o un maestro elementare?
Contro questa
visione tanto parziale quanto limitata dell’istruzione
centinaia di studiosi inglesi hanno recentemente firmato un documento dove si afferma “
che l’istruzione superiore ha benefici sia pubblici che privati e che i benefici pubblici necessitano di un sostegno finanziario, che le università pubbliche sono necessarie per costruire e mantenere la fiducia nel dibattito pubblico, che le università pubbliche hanno una missione sociale e contribuiscono a migliorare la disuguaglianza sociale, che la pubblica istruzione superiore è parte di un contratto generazionale, in cui una generazione più vecchia investe nel benessere delle generazioni future, che le istituzioni pubbliche che forniscono programmi simili di studio dovrebbero essere parimenti finanziate, che l’istruzione non può essere trattata come un semplice bene di consumo, che la formazione di competenze non è la stessa cosa della formazione universitaria e, infine, che le università sono non solo delle istituzioni globali, ma devono anche servire le loro comunità locali e regionali.”
Quello che si può e si deve fare è cercare di migliorare l’esistente: il finanziamento statale all’istruzione superiore, come anche alla ricerca di base, rappresenta un contributo imprescindibile per qualsiasi società avanzata in quanto istruzione e ricerca fanno parte di quelle
infrastrutture di un paese che ne determinano le prospettive, a breve e a lungo termine, di
crescita economica e civile.