
| LA MISURA DEL POTERE PER I BARONI DELLA CONOSCENZA |
La questione dell’università in Italia non riguarda il malaffare. Dire questo (si tranquillizzino i Travaglio, i Saviano e la fiorente editoria che campa sugli archivi di magistratura e polizia) non significa che non ci siano corrotti, al contrario. Significa invece spostare l’attenzione sulla struttura: è il sistema che produce corruzione, non sono i corrotti a determinare il sistema. Mostrarlo è un grande merito di Francesco Sylos Labini e Stefano Zapperi, in un libro rigoroso e utile: su ricercatorialberi.blogspot.com commenti e recensioni (tra cui Roberta Carlini) testimoniano la capacità dei due fisici di aprire un dibattito sull’università non cannibalizzato dalla fame di scandali dell’opinione pubblica giustizialista.
I mali diagnosticati non sono inediti: lo storico sottofinanziamento della ricerca, l’irreversibile invecchiamento del corpo docente, il drammatico blocco del turn-over, le nefaste conseguenze delle politiche di Gelmini-Tremonti. Ma la dovizia di particolari e dati rende le argomentazioni ulteriormente convincenti e difficilmente controvertibili. Analizzando la struttura demografica, ad esempio, si mostra come il 56% dei docenti sia ultracinquantenne, mentre solo il 2% ha meno di trent’anni. Lette all’interno del sistema a code dell’università italiana, queste cifre spiegano non solo perché la precarietà sia (qui come altrove) un elemento strutturale del funzionamento degli atenei, ma anche perché – essendo la norma e non l’eccezione – non vi sia possibilità di riassorbimento, configurando piuttosto una lotta che avrà un forte aspetto generazionale.
Se la condanna delle politiche della maggioranza è, giustamente, senza appello, non si trova – altrettanto correttamente – alcuna fiducia nei “progetti” dell’opposizione. Così, se nel 2008 Berlusconi ha sacrificato i soldi per i progetti di ricerca al (fallimentare) salvataggio di Alitalia, l’anno prima il governo Prodi aveva dirottato i fondi agli autotrasportatori. La strategia di abbandono di formazione e ricerca è, dunque, interamente bipartisan. Un’assenza di idee riempita da una soffocante centralizzazione statalista e dall’ipernormativismo burocratico (come dimostrano il caso del Cnr e il Ddl Gelmini), in cui i drastici tagli devono essere compensati dall’aumento delle rette e dal basso costo della forza lavoro. È la ricetta di Perotti: la crisi la paghino studenti e precari.
“Liberalizzare” e “privatizzare” sono le parole magiche a cui gli autori si oppongono. Ma in un paese in cui i privati investono meno dell’1% nell’università e sono dopati dai soldi pubblici, la parola d’ordine centrale è “dismissione”, per conservare le posizioni di rendita e di potere che i riformatori giavazziani non si sognano affatto di toccare. Passando alle “terapie”, allora, è evidente che il primo nemico da abbattere è la struttura feudale. Prendiamo la questione del reclutamento: dopo l’ennesima inutile alchimia legislativa, è ormai chiaro a tutti che sono proprio i concorsi a perpetuare quello che gli autori chiamano lo “ius primae noctis” riservato ai baroni. Non possiamo allora dire che vanno aboliti? Perché non ipotizzare – tuffandosi in un coraggioso dibattito – una forma di chiamata diretta dall’anagrafe dei precari in cui i docenti paghino in prima persona (e sarebbe la prima volta) le scelte che fanno? Non consentirebbe forse ai precari da un lato maggiore mobilità, possibilità di reddito e aggregazione orizzontale, dall’altro di svincolarsi dal sistema a code e di individuare i reali rapporti di sfruttamento dentro l’università? Ciò permetterebbe, inoltre, di separare ciò che l’attuale trend aziendalistico-feudale unifica: valutazione e meritocrazia, ossia il lavoro vivo che produce i saperi e la misura artificiale che lo gerarchizza. Fare della valutazione un campo di battaglia, renderla immanente alla cooperazione sociale, significa dunque porre il problema della decisione sui fondi, sui salari e sul welfare, non abbandonarla al potere feudale, al disinvestimento dello Stato e al parassitismo privato. E se qualcuno grida alla complicità con il “neoliberismo”, faccio presente che, mutatis mutandis, il punto di vista è analogo a quello di Lenin nella polemica con i populisti sullo “sviluppo del capitalismo”. Quantomeno, la compagnia è buona.
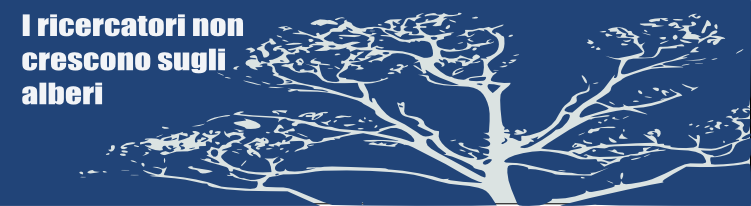




Nessun commento:
Posta un commento