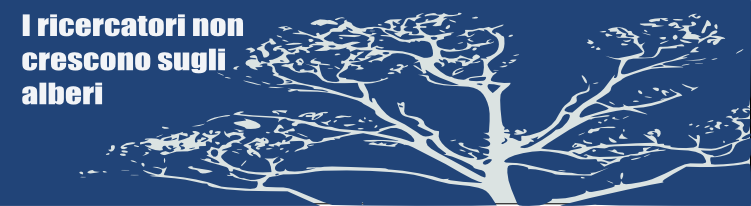"I ricercatori non crescono sugli alberi" è il titolo del libro scritto a quattro mani da Francesco Sylos Labini e Stefano Zapperi sulla ricerca e l'università in Italia. E' stato pubblicato da Laterza a gennaio 2010. A cosa serve la ricerca, perché finanziarla, cosa fanno i ricercatori, che relazione c'è tra ricerca ed insegnamento, come riformare il sistema della ricerca e dell'università, a quali modelli ispirarsi. Due cervelli non in fuga denunciano la drammatica situazione italiana e cosa fare per uscire dalle secche della crisi. Perché su una cosa non c'è dubbio: se ben gestito, il finanziamento alla ricerca non è un costo ma l'investimento più lungimirante che si possa fare per il futuro del paese e delle nuove generazioni.
martedì 15 maggio 2012
sabato 28 aprile 2012
venerdì 6 aprile 2012
Chi valuta i valutatori? | Francesco Sylos Labini | Il Fatto Quotidiano
Chi valuta i valutatori? | Francesco Sylos Labini | Il Fatto Quotidiano
...In totale si avranno circa 250,000 pubblicazioni da esaminare e il costo dell’intera operazione può essere stimato essere di circa 300 milioni di euro. Ricordandoci che il finanziamento all’università si posiziona agli ultimi posti tra i paesi con cui vorremmo “competere”, ci si chiede se a questo notevole investimento di risorse pubbliche corrisponderà un adeguato “ritorno”. Chiaramente la risposta a questa domanda dipende da come sarà eseguita la valutazione...
...In totale si avranno circa 250,000 pubblicazioni da esaminare e il costo dell’intera operazione può essere stimato essere di circa 300 milioni di euro. Ricordandoci che il finanziamento all’università si posiziona agli ultimi posti tra i paesi con cui vorremmo “competere”, ci si chiede se a questo notevole investimento di risorse pubbliche corrisponderà un adeguato “ritorno”. Chiaramente la risposta a questa domanda dipende da come sarà eseguita la valutazione...
venerdì 10 febbraio 2012
sabato 14 gennaio 2012
giovedì 29 dicembre 2011
domenica 18 dicembre 2011
giovedì 1 dicembre 2011
domenica 27 novembre 2011
giovedì 13 ottobre 2011
Università e ricerca, trasformazioni e prospettive in tempo di crisi
Video intervista a Francesco Sylos Labini, ricercatore al Cnr di Roma, protagonista della seconda giornata degli incontri catanesi ce fanno parte delle "lezioni di crisi" che ricercatori e docenti delle università stanno organizzando in tutta Italia.
Vai al link del video
Vai al link del video
Etichette:
intervista
martedì 11 ottobre 2011
Fondi alla Ricerca
Appello pubblico in favore del finanziamento della Ricerca Scientifica e Tecnologica in Italia
Le prime 200 adesioni di accademici da tutte le Università italiane alla campagna
I rappresentanti del mondo accademico, in collaborazione con l’IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Italy Section) e con Key4biz, lanciano la campagna per l’assegnazione di parte dei proventi dell’asta delle frequenze LTE a favore della ricerca scientifica e tecnologica nel nostro Paese.
Quali gli obiettivi? Un’attenzione alla Ricerca, un sostegno ai giovani, un beneficio per le imprese, il mercato e i consumatori, infine un contributo alla crescita e alla rinascita della nazione.
La recente asta per le frequenze ha generato un incasso per lo Stato di quasi 4 Miliardi di Euro e da più parti si avanzano proposte su come impiegare i fondi ricavati in eccesso rispetto alle attese. Noi riteniamo che una quota di questi fondi potrebbe essere destinata alla Ricerca Scientifica e Tecnologica, dando così un importante segnale ai ricercatori, principalmente ai più giovani, che l’Italia crede nella loro creatività e nel loro impegno, qualità fondamentali per la ripresa e per la competitività internazionale del Paese.
Siamo certi che questa iniezione di fiducia non tarderebbe a dare buoni frutti…
Etichette:
appelli
giovedì 29 settembre 2011
Valutare la ricerca?
L’università italiana cambia. Una serie di interventi legislativi ha ridisegnato l’organizzazione interna dell’università pubblica, mutandone profondamente la governance. Sono state modificate anche le procedure per il reclutamento dei docenti e dei ricercatori Inoltre, un sistema di valutazione dovrebbe presto entrare in funzione a pieno regime, introducendo novità significative, che avranno conseguenze per il reclutamento, le progressioni di carriera e il finanziamento degli atenei. Si tratta di provvedimenti che riprendono in parte spunti emersi in decenni di dibattito sui difetti dell’università pubblica italiana.
Il modo in cui tali provvedimenti sono stati concepiti e portati avanti dall’attuale governo non ne inficia taluni aspetti positivi: occorre infatti ripristinare la capacità di tener fede alla propria missione istituzionale da parte degli atenei del paese, così come l’immagine dell’Università italiana all’interno del paese stesso. Tuttavia, un giudizio sulle buone intenzioni del cuoco non garantisce affatto che tutte le pietanze che prepara siano ugualmente ben riuscite. Ce ne saranno di buone e di meno buone, e non si può escludere che qualcuna si riveli, con il tempo, nociva per la salute di chi se ne ciba.
La ragione per cui poniamo questo problema è che nell’università lavoriamo, e vorremmo continuare a fare il nostro lavoro nel modo migliore a lungo. Infatti, contrariamente a quel che certe campagne di stampa vorrebbero far credere, l’università italiana non è fatta solo di “precari” e “baroni”. Ci sono migliaia di ricercatori e professori nella fascia d’età tra i trentacinque e i quarantacinque anni. Preparati, spesso con esperienze di ricerca all’estero, e con pubblicazioni internazionali. Persone che hanno investito e vogliono continuare a investire tempo e passione nell’università di questo paese, le cui voci fino ad ora hanno trovato ben poco accoglienza da parte degli organi di stampa e hanno faticato a raggiungere l’opinione pubblica.
Per questo abbiamo ritenuto utile promuovere un incontro che si terrà all’università di Milano (il 30 settembre, aula 420 di via Festa del Perdono, ore 11.00) per discutere delle pietanze che stanno per esserci servite, cominciando dalla valutazione della ricerca individuale e dall’impatto che essa avrà sul reclutamento e sulla carriera di docenti e ricercatori. Invitiamo tutti coloro che sono interessati a partecipare e, se ritengono, a portare il proprio contributo di idee per aiutarci a capire se ci sono aspetti del sistema di valutazione che si prospetta che potrebbero essere migliorati, anche alla luce delle critiche cui vengono sottoposti sempre più di frequente quelli in vigore già da tempo in altri paesi, in particolare nel Regno Unito, cui il nostro è parzialmente ispirato.
Antonio Banfi Mario Ricciardi Vito Velluzzi
Sono previsti interventi di Alberto Baccini, Giuseppe de Nicolao, Francesco Sylos Labini, e tanti altri.
Slides di Alberto Baccini
Slides di Giuseppe de De Nicolao
Slides di Francesco Sylos Labini
Slides di Alberto Baccini
Slides di Giuseppe de De Nicolao
Slides di Francesco Sylos Labini
Etichette:
valutazione
mercoledì 28 settembre 2011
Istruzione pubblica e vantaggi pubblici
La quantità della spesa è dunque un aspetto rilevante del problema che va considerato in tanti ambiti, a cominciare dall’obiettivo di aumentare il numero di laureati garantendo seriamente il diritto allo studio. Per semplificare possiamo immaginare due modelli antitetici per reperire le risorse. Nel primo, essenzialmente quello attuale in Italia come nella maggior parte dei paesi europei, l’istruzione e la ricerca sono pubbliche e finanziate dalla fiscalità generale più dalle tasse universitarie. Entrambe queste tassazioni (circa 80% e 20% del totale della spese) sono basate su aliquote progressive con il reddito.
Nel secondo modello si parte dal presupposto che lo Stato è inefficiente ed il sistema non è riformabile: mentre il mercato crea ricchezza, lo Stato è parassita. Riversando il costo dell’università direttamente sugli utenti (le famiglie) si dovrebbero innescare dei meccanismi di mercato che farebbero aumentare vorticosamente e magicamente la qualità del sistema universitario. Per questi motivi, seguendo la recente esperienza inglese, bisognerebbe consentire agli atenei di aumentare le tasse universitarie per tutti gli studenti anticipando, a carico dello Stato, il costo sostenuto dagli studenti meno abbienti per frequentare l’università. Bisognerebbe consentire poi, agli studenti beneficiati del prestito, di ripagare il debito in futuro, ma solo se e quando raggiungeranno un reddito sufficientemente elevato
Mentre in Inghilterra c’è stato un furioso dibattito sull’introduzione di questo modello da parte del governo Cameron, in Italia c’è chi utilizza ogni occasione possibile per riproporre questa soluzione, o varianti di questa (vedi ad esempio qui). Questa tesi viene giustificata dal fatto che è necessario evitare che “i poveri finanzino la laurea ai ricchi” come adesso avverebbe in quanto i poveri vanno poco all’università. Dunque, anche se a prima vista non sembrerebbe, visto che di colpo, a parità di fiscalità generale, le tasse universitarie aumenterebbero di un fattore 5/10 (o anche più), questa soluzione viene presentata come un modello a vantaggio dei “poveri”: si tratterebbe dunque di una proposta di sinistra tanto che si cerca di convincere il Pd a farla propria.
Gli argomenti usati fanno tuttavia acqua da tutte le parti. Ad esempio, poiché le aliquote, dirette ed indirette, sono progressive con il reddito non è vero che nel sistema attuale i “poveri” pagano l’università ai “ricchi”: se ci fosse uno sbilanciamento in questo senso (cosa da dimostrare) sarebbe comunque sufficiente abbassare relativamente le aliquote dei ceti meno abbienti rispetto a quelle dei ceti più abbienti per riequilibrare la situazione. Il meccanismo più ideologico e denso di potenzialità distruttive di questa proposta è legato alla restituzione del debito: se lo studente trova un buon lavoro restituisce i soldi allo Stato, altrimenti è l’ateneo che deve restituirli. In questo modo gli atenei si vedono costretti ad agire come imprese private: investono sulla possibilità che i propri studenti trovino lavori ben remunerati.
Diventa così il mercato del lavoro a influenzare cosa s’insegna e, minimizzando il rischio, si è naturalmente portati a concedere prestiti a studenti provenienti da famiglie più abbienti che studiano materie più vicine al mondo delle professioni; analogamente, l’accorto investitore-studente sceglierà gli studi potenzialmente più remunerativi. Si presuppone, dunque, che l’istruzione sia un investimento personale finalizzato all’incremento del reddito a vantaggio del singolo e non della collettività e che il valore sociale di un’attività lavorativa venga misurato dal reddito che se ne ricava e non anche, o sopratutto, dall’utilità sociale di questa: è più utile socialmente un promoter finanziario o un maestro elementare?
Contro questa visione tanto parziale quanto limitata dell’istruzione centinaia di studiosi inglesi hanno recentemente firmato un documento dove si afferma “che l’istruzione superiore ha benefici sia pubblici che privati e che i benefici pubblici necessitano di un sostegno finanziario, che le università pubbliche sono necessarie per costruire e mantenere la fiducia nel dibattito pubblico, che le università pubbliche hanno una missione sociale e contribuiscono a migliorare la disuguaglianza sociale, che la pubblica istruzione superiore è parte di un contratto generazionale, in cui una generazione più vecchia investe nel benessere delle generazioni future, che le istituzioni pubbliche che forniscono programmi simili di studio dovrebbero essere parimenti finanziate, che l’istruzione non può essere trattata come un semplice bene di consumo, che la formazione di competenze non è la stessa cosa della formazione universitaria e, infine, che le università sono non solo delle istituzioni globali, ma devono anche servire le loro comunità locali e regionali.”
Quello che si può e si deve fare è cercare di migliorare l’esistente: il finanziamento statale all’istruzione superiore, come anche alla ricerca di base, rappresenta un contributo imprescindibile per qualsiasi società avanzata in quanto istruzione e ricerca fanno parte di quelle infrastrutture di un paese che ne determinano le prospettive, a breve e a lungo termine, di crescita economica e civile.
Etichette:
tasse
martedì 6 settembre 2011
Festival della Letteratura
PERCHE' DOBBIAMO PAGARE UNO SCIENZIATO (QUANDO FACCIAMO LE MIGLIORI SCARPE DEL MONDO)? 09/09/2011 - 14:30, Conservatorio di musica Lucio Campiani - Chiostro
Lo scorso autunno studenti e ricercatori sono saliti sui tetti, seguendo gli operai cassintegrati e gli immigrati irregolari. Il tumulto nelle università è presto uscito di scena dai media nazionali per far posto alle spese natalizie, ma il disagio - e l’emorragia dall’Italia di giovani formati a spese della collettività - persiste. A cosa serve la ricerca in un paese che ha dato grandi contributi scientifici, ma che molti oggi dicono “a vocazione turistica”? È redditizio spendere per la ricerca fondamentale, e come può intervenire il privato? Come si coniuga autonomia del ricercatore e valutazione del suo lavoro? Lo stato e le potenzialità della ricerca scientifica in Italia saranno analizzati da Giulio Peruzzi, professore di storia della scienza dell’Università di Padova, e da Francesco Sylos Labini, astrofisico del Centro Enrico Fermi e blogger.LA DISTANZA DELLE STELLE (LAVAGNE - Problemi scientifici (e musicali) in piazza) 08/09/2011 - 20:30, Piazza Mantegna , ingresso libero
(Francesco Sylos Labini) Quant’è grande l’Universo “visibile”, e come si misura? Dal 2000 a.c. al 2011 d.c., l’uomo, relegato sulla superficie della piccola sfera terrestre, è stato in grado di misurarsi con le distanze siderali.
Etichette:
presentazioni
mercoledì 31 agosto 2011
Fluttuazioni economiche selvagge di mezz’estate
Tra i ragionamenti che rimbalzano sulle prime pagine dei quotidiani, della crisi economica riesplosa con grande virulenza questo agosto (mese abbastanza a rischio, a quanto pare), ce n’è uno che, semplificando, può essere così riassunto:
(1) Quello che è avvenuto mostra che i mercati alle volte falliscono.
(2) I governi e la politica falliscono più gravemente dei mercati.
(3) Dunque non possiamo sperare (pretendere?) che i governi, che questa volta come tante altre non hanno dimostrato le capacità di “salvarci” dalla crisi economica, potranno prendere in mano la situazione. L’unica possibilità è che i mercati, auto-regolandosi (magari una volta “liberati” dalla residua intromissione dello Stato), possano in qualche modo imporre agli Stati le politiche economiche “giuste” che siano in grado di ricondurci verso la retta via dell’ “equilibrio”.
A mio avviso la conclusione (3) è sbagliata prima di tutto in quanto sono sbagliate le premesse (1,2). Innanzitutto: in che senso i meccanismi di mercato falliscono? Falliscono rispetto a cosa? Quello che succede nei periodi di crisi economica, e in modo speculare nei periodi di boom economico, dal punto di vista, ad esempio, dei prezzi delle azioni, sono delle grandi fluttuazioni: le crisi rappresentano delle grandi variazioni negative dei prezzi. Dunque, la domanda è: queste fluttuazioni così grandi sono degli eventi davvero così improbabili come i modelli economici predicono?
I prezzi non si possono predire, ma le loro fluttuazioni possono essere descritte matematicamente. Il punto critico riguarda il tipo di descrizione statistica che si assume (o si misura) nei dati. Un’assunzione fondamentale, ipotizzata da un matematico francese, Louis Bachelier, agli inizi del secolo scorso, e usata, in modo più sofisticato, dai modelli finanziari correnti, è che le variazioni dei prezzi siano statisticamente indipendenti: quello che succede oggi è indipendente da quello che è successo ieri, e dunque quello che succederà domani è indipendente da quello che è successo oggi; inoltre quello che fa un agente di borsa è indipendente da quello che fa un altro.
Questo tipo di schema teorico porta però a delle conclusioni paradossali: ad esempio le variazioni dei prezzi così grandi, come quelle a cui stiamo assistendo in questi giorni, ma che abbiamo già visto ripetersi tante altre volte nel recente e prossimo passato (il martedì nero del 1987, la crisi delle economie asiatiche del 1997, ecc.), dovrebbero avvenire, secondo questi modelli, un volta ogni centinaia di migliaia di anni o più. Gli economisti ortodossi invocano allora la presenza di calamità “naturali” che fanno sballare tutte le predizioni, o che, più prosaicamente, fanno accadere eventi improbabili a ripetizione. Ma forse, più semplicemente, come ha discusso Benoit Mandelbort, uno dei matematici e pensatori più influenti ed importanti del 900, nel suo libro “Il disordine dei mercati” le assunzioni alla base dei modelli ortodossi sono completamente sbagliate e i cambiamenti repentini ed estremi dei prezzi sono la norma nei mercati finanziari e non delle aberrazioni che possono essere ignorate.
Perché dunque vi sono variazioni dei prezzi (o fluttuazioni) così grandi (Nassim Nicholas Taleb, le chiama “Il cigno nero”)? Avvengono perché ci sono degli eventi correlati, ovvero perché tanti agenti di borsa fanno contemporaneamente la stessa cosa: vendono (o comprano) le stesse azioni. Perché quello che è avvenuto nel passato influenza quello che succede nel presente e che avverrà nel futuro. In altre parole, appaiono fenomeni coerenti su grandi scale temporali e spaziali: in termini tecnici si formano correlazioni a lunga portata. La presenza di queste correlazioni non è contemplata dai modelli economici basati sull’indipendenza degli eventi (ovvero statistica Gaussiana ).
La descrizione ortodossa delle fluttuazioni dei prezzi, dunque, non solo non è capace di prevedere, ma neppure di interpretare, quello che succede nella realtà. Ovviamente, non è la realtà a fallire, quanto piuttosto la pretesa che i mercati siano capaci di auto-regolarsi e siano caratterizzati da piccole e indipendenti fluttuazioni. In realtà dunque il punto (1) diventa: (1a) le fluttuazioni tipiche dei mercati finanziari sono grandi (o selvagge).
Non sono perciò i mercati che falliscono rispetto a un andamento “teorico” che prevede l’assenza di grandi variazioni che sono invece intrinseche ai mercati finanziari. Sono piuttosto i modelli teorici a essere basati su assunzioni (o dogmi) irrealistici rispetto alla realtà. E sono i mercati stessi portatori di situazioni d’instabilità; l’idea che i mercati tendano ad auto-regolarsi raggiungendo una situazione di “equilibrio” è contraddetta infatti dalla semplice analisi delle serie temporali delle variazioni dei prezzi. Ed è dunque semplicemente irrealistico pensare che i mercati costringano i politici a “comportarsi bene”. Serve piuttosto la buona politica, quella che è capace di pensare al bene comune, che guarda lontano nel tempo e che per queste ragioni ha consenso, per iniziare a pensare a come regolare una roulette russa globale che ci sta rapidamente portando verso una catastrofe annunciata: non mi sembra ci sia un’altra strada possibile.
(Il Fatto Quotidiano)
venerdì 29 luglio 2011
Numeri e percezione dell’università italiana
 Ho avuto modo di commentare sulla perseveranza di un certo gruppo d’economistinell’affermare che l’università italiana non sia riformabile o addirittura che “la ricerca che oggi produce in media la miglior università italiana è del livello di quella che Harvard – la frontiera odierna – produceva tra il 1950 e il 1970” (?). Secondo loro, non solo la ricerca italiana è di basso livello ma la corruzione è dilagante e i costi esorbitanti. D’altra parte, molti studi (vedi qui e qui) mostrano che la ricerca scientifica italiana non è affatto di basso livello, ma che in termini qualità e quantità è complessivamente entro le prime sette posizioni al mondo. Questo avviene in una situazione in cui le risorse che lo Stato investe nell’istruzione università e nella ricerca sono certamente molto minori della gran parte dei paesi Ocse e di sicuro di quelli che ci prendono nelle classifiche.
Ho avuto modo di commentare sulla perseveranza di un certo gruppo d’economistinell’affermare che l’università italiana non sia riformabile o addirittura che “la ricerca che oggi produce in media la miglior università italiana è del livello di quella che Harvard – la frontiera odierna – produceva tra il 1950 e il 1970” (?). Secondo loro, non solo la ricerca italiana è di basso livello ma la corruzione è dilagante e i costi esorbitanti. D’altra parte, molti studi (vedi qui e qui) mostrano che la ricerca scientifica italiana non è affatto di basso livello, ma che in termini qualità e quantità è complessivamente entro le prime sette posizioni al mondo. Questo avviene in una situazione in cui le risorse che lo Stato investe nell’istruzione università e nella ricerca sono certamente molto minori della gran parte dei paesi Ocse e di sicuro di quelli che ci prendono nelle classifiche.Perché dunque quegli economisti, che pure avrebbero tutto l’interesse a dimostrare in maniera quantitativa le loro affermazioni per non passare per dei superficiali motivati da altri interessi che non sia il bene comune di avere un sistema universitario e della ricerca che funzioni meglio di quello attuale, hanno una visione così caricaturale del sistema italiano? Non sarà che parlano, oltretutto in modo strumentale, solo di quel poco che conoscono? Siamo dunque andati a cercare dei numeri che in qualche modo possono illustrare direttamente la “qualità” d’alcune discipline in Italia. Abbiamo trovato due ricerche: la prima riguarda i docenti di fisica e la seconda i docenti di economia. E’ interessante vedere cosa s’impara da questi dati.
La prima ricerca è stata effettuata da Paolo Rossi, fisico dell’Università di Pisa, che ha raccolto gliH-index dei fisici italiani (professori ordinari, associati e ricercatori: circa 3000 unità al 2007). Ricordiamo che un ricercatore ha H-index pari, ad esempio, a 10 se le sue 10 pubblicazioni più citate hanno ognuna 10 o più citazioni e le altre pubblicazioni hanno un minor numero di citazioni. L’H-index si costruisce sulle pubblicazioni presenti su riviste censite da banche dati certificate e fornisce sicuramente un’approssimata ed incompleta misura della qualità della produzione scientifica d’un ricercatore: rimando qui per una discussione critica di questo indicatore bibliometrico.
Dallo studio di Rossi risulta che il 50% dei professori associati e dei ricercatori in fisica, che hanno delle distribuzioni quasi identiche, ha un indice H superiore a 10, mentre il 50% degli ordinari ha un indice H superiore a 15. Quest’ultima differenza è naturale in quanto l’H-index cresce con il tempo, e dunque va diviso per gli anni di carriera. D’altra parte, visto che in media i ricercatori sono più giovani dei professori associati, è anche possibile concludere che siano più produttivi. Inoltre una buona parte (circa il 60%) degli associati e dei ricercatori ha un indice H tra 5 e 15, mentre il 50% degli ordinari ha un indice H compreso tra 10 e 20. Vi è poi una percentuale più piccola di docenti che hanno un alto indice H, con valori che possono superare 30 o 40: è ben noto che la fisica italiana brilli a livello internazionale.
La seconda ricerca è stata effettuata da Cristina Marcuzzo e Giulia Zacchia, economisti dell’università “Sapienza” di Roma, che hanno utilizzato la banca dati Econlit, che censisce pubblicazioni rilevanti nel campo dell’economia. Uno dei dati che più risaltano da quest’analisi è che ben il 16% degli economisti accademici ha zero records su Econlit. E’ ovvio che avere zero pubblicazioni implica che almeno la stessa frazione di docenti abbia ricevuto zero citazioni e zero H index: probabilmente questo elevato numero di zeri riflette il fatto che molti docenti s’occupano d’altro. Le due autrici hanno poi esaminato quanti dei docenti in ruolo passerebbero gli “indicatori minimali di qualificazione scientifica” del Consiglio Universitario Nazionale (Cun) per l’accesso ai tre livelli della carriera universitaria (e sarebbe interessante ripetere questo esercizio per i criteri di valutazione emanati dall’Anvur):
“Il nostro esercizio mostra che le asticelle da superare poste dal Cun sono molto al di sopra del livello medio della produzione degli economisti ….. Solo il 27,4 per cento degli ordinari risulta avere dieci pubblicazioni censite in Econlit negli ultimi otto anni … Per gli associati, la prima soglia nel proprio ruolo è superata dal 16,2 per cento dei confermati… Nel caso dei ricercatori, la situazione è migliore: il 65,8 per cento soddisfa il criterio previsto per quella fascia; tuttavia, meno del 10 per cento ha le caratteristiche per diventare associato, e un gruppo piccolo ha anche “i numeri” per diventare ordinario”. Concludono il loro studio sottolineando che “non si può non tener conto che i criteri proposti risultano soddisfatti solo da una piccola percentuale degli economisti accademici italiani, con la sola eccezione forse deiricercatori”.
Questa conclusione è confermata da un altro studio in cui è stato misurato l’indice H per i 696 ordinari delle discipline economiche con la conclusione che: “La distribuzione è fortemente asimmetrica, con oltre il 40 per cento dei docenti con valori di H compresi tra 0 e 2, e solo il 5 per cento con superiori a 16.” Insomma, c’è un’evidente differenza rispetto al caso dei fisici. Se è naturale (vedi qui) che ci siano differenze nelle modalità di pubblicazione e citazione tra kdiversi campi campi, se è vero che ci possono essere nei campi umanistici delle dinamiche sociologiche molto rilevanti che alterano il significato degli indici bibliometrici, è piuttosto anomalo non solo il basso indice H della metà dei professori ordinari di economia (minore o uguale a 2!) ma anche il fatto che una buona percentuale dei docenti delle tre fasce non ha proprio nessuna pubblicazione su banche dati internazionali. Che sia allora questa differenza all’origine della diversa percezione della qualità della ricerca nell’università italiana? Se lo fosse, saremmo comunque sorpresi dalla superficialità con cui è stata fatta di tutta l’erba un fascio e dalla determinazione con cui è stata, ed è tuttora, denigrata tutta la ricerca italiana. Se non lo fosse: peggio ancora.
Etichette:
economia,
fisica,
valutazione
mercoledì 20 luglio 2011
Futuro in ricerca?
In Italia, per superare la pre-selezione nel 2010 è stato necessario avere il punteggio pieno (60/60). Il punteggio totale non è altro che la somma di punteggi parziali su quattro voci (originalità, merito scientifico, fattibilità, qualità del gruppo di ricerca) assegnate da due “arbitri” (referees) che devono esprimere un giudizio condiviso. E’ dunque evidente che per avere il punteggio pieno non basta che il progetto sia di qualità, ma è necessario che gli arbitri non abbiano alcun dubbio e soprattutto che non esitino a dare sempre il massimo dei voti, cosa non scontata anche perché il giudizio su ogni progetto è fatto a prescindere dagli altri. Alla fine la differenza tra essere finanziati o meno si gioca su 1 voto su 60. Ci si può allora domandare quale sia il senso di questa procedura di valutazione se è sufficiente un dettaglio per compromettere un progetto: è ovvio che la probabilità di successo chiaramente diminuisce quando si imposta la propria ricerca su qualche tema non consolidato o minimanente controverso.
La domanda che bisogna porsi è se questo tipo di meccanismo d’assegnazione dei fondi renda davvero migliore la ricerca scientifica, a fronte, soprattutto in Italia, della quasi totale assenza di altre fonti di finanziamento della ricerca di base. Inoltre, bisognerebbe inquadrare il problema in maniera più completa e considerare anche quanto “costa” il tempo che i giovani ricercatori impiegano per preparare dei progetti che al 98% non verranno finanziati. Leo Szilard, uno dei più brillanti fisici del XX secolo, scrisse vari racconti ed in uno di questi, La fondazione Mark Gable, si narra la storia di un miliardario che chiede ad un ricercatore come si possa rallentare il progresso della scienza, secondo lui troppo rapido. Il ricercatore risponde:
“Lei potrebbe creare un istituto, con un finanziamento annuale di quaranta milioni di dollari. I ricercatori che abbiano bisogno di capitali potrebbero rivolgersi a questo istituto, purché presentino tesi convincenti. Nomini dieci comitati, ciascuno composto di dodici scienziati, con l’incarico di esaminare queste domande. Prenda dai laboratori gli scienziati più attivi e li faccia membri di questi comitati. […] Prima di tutto, i migliori scienziati sarebbero in questo modo allontanati dai loro laboratori e occupati nel lavoro dei comitati preposti all’assegnazione dei finanziamenti. Secondariamente, i ricercatori scientifici bisognosi di capitali si concentrerebbero su problemi ritenuti promettenti e tali da condurre con sicurezza a risultati pubblicabili. Per qualche anno ci sarebbe un forte incremento della produzione scientifica, ma ragionando a lume di naso, questo sarebbe proprio il sistema adatto per inaridire la scienza. […] Ci sarebbero ricerche considerate interessanti, altre no. Sarebbe una questione di moda. Chi segue la moda, ha i prestiti. Chi non la segue, no. E vedrà che faranno in fretta a imparare a seguir la moda anche loro.”
Invece di perdere tempo nell’escogitare nuove, raffinate e probabilmente inutili tecniche di valutazione allo scopo di identificare una presunta eccellenza, bisognerebbe porsi la semplice domanda se sia sensato finanziare una frazione marginale di progetti di ricerca: la risposta a questa domanda va cercata nella storia recente della ricerca, che andrebbe analizzata in dettaglio e con senso critico.
(Pubblicato su Il fatto quotidiano)
Etichette:
valutazione
mercoledì 13 luglio 2011
La scienza del culto dei cargo
La discussione su che tipo di disciplina sia l’economia, oggetto del mio ultimo post, ha generato un gran dibattito nei commenti. Non potendo rispondere a tutti vorrei precisare dei punti che forse sono stati malintesi da parte di qualcuno. Il primo punto è che non sostengo affatto che le scienze esatte (scusate per la traduzione maccheronica di hard science) siano migliori delle altre discipline, ma che l’oggetto di studio è differente e soprattutto più limitato: queste condizioni permettono di usare una metodologia più rigorosa. Ad esempio, in fisica ci si occupa di problemi molto circoscritti proprio perché si pretende tantissimo, ovvero si pretende che una teoria sia falsificabile e gli esperimenti siano riproducibili. Una teoria è falsificabile se è capace di fare delle predizioni quantitative di fenomeni non ancora noti che possono essere testate nei dati (oltre chiaramente a spiegare quello che già si conosce).
Per soddisfare queste condizioni bisogna sacrificare parecchio e limitarsi a fenomeni piuttosto semplici se paragonati alla complessità della dinamica umana, perché in pratica significa che è necessario controllare le condizioni al contorno di un fenomeno naturale: isolare la causa di ogni fenomeno, valutare ogni effetto singolarmente, ecc. Nel caso delle scienze naturali troviamo inoltre diverse gradazioni: dalla situazione in cui gli esperimenti sono fattibili in laboratorio in diverse condizioni, come in fisica, in chimica, ecc., al caso delle scienze che sono invece principalmente basate sulle osservazioni, come ad esempio la geologia o l’astrofisica. Inoltre, come ci ha insegnato la storia della scienza, non basta costruire, usando la matematica, un’apparente rigore scientifico. Per andare al punto vorrei riproporre l’illuminante lezione magistrale sul senso della scienza e dell’etica scientifica del famoso fisico Richard Feynman:
“Nei mari del Sud vive un popolo che pratica infatti il culto dei cargo: durante la seconda guerra mondiale hanno visto atterrare aerei carichi di ogni ben di Dio, ed ora vorrebbero che la cosa continuasse. Hanno tracciato sul terreno delle specie di piste; accendono fuochi ai loro lati; hanno costruito una capannuccia in cui si siede un uomo con due pezzi di legno a mo’ di cuffie, e da cui sporgono dei bambù a mo’ d’antenne radio (l’uomo rappresenta il controllore di volo); ed aspettano che gli aerei atterrino. Fanno tutto correttamente; la forma è perfetta e rispetta quella originale: ma la cosa non funziona. Non atterra nessun aereo.
Così parlo di scienze da cargo cult: sono scienze che seguono i precetti e le forme apparenti dell’indagine scientifica ma alle quali, però, manca un elemento essenziale, visto che gli aerei non atterrano. A questo punto dovrei indicarvi l’elemento mancante. Sarebbe però altrettanto difficile dello spiegare agli isolani dei mari del Sud come procedere per far funzionare il loro sistema ed arrivare ad un certo benessere. Non si tratta di una cosa semplice, come dir loro di migliorare la forma delle cuffie. Ma c’è soprattutto una cosa che in genere manca nelle scienze da cargo cult: un’idea che tutti ci auguriamo abbiate imparato a scuola; non la esplicitiamo mai, speriamo che la scopriate da soli grazie a tutti gli esempi di indagine scientifica che avete studiato. Ora invece sarà interessante formularla apertamente.
Si tratta dell’integrità scientifica. Un principio del pensiero scientifico che corrisponde essenzialmente ad una totale onestà, ad una disponibilità totale. Per esempio, quando si effettua un esperimento bisogna riferire tutto ciò che potrebbe invalidarlo, e non soltanto quello che sembra in accordo con le aspettative; le altre cause che potrebbero insomma originare gli stessi risultati… (…) …Sappiamo per esperienza che la verità finisce sempre col venire a galla. Altri scienziati ripeteranno il vostro esperimento, e scopriranno se era corretto o no. I fenomeni della natura saranno o no in accordo con la vostra teoria. E magari otterrete una fama temporanea ma, se non avrete lavorato con accuratezza, la vostra reputazione di scienziato non sarà buona. Sono questa integrità, questa volontà di non autoingannarsi, che mancano alla ricerca delle scienze da cargo cult… Vi auguro una cosa sola: la fortuna di trovarvi sempre in una situazione che vi consenta di mantenere liberamente l’integrità di cui ho parlato, e di non sentirvi costretti a perderla per conservare il posto, trovare fondi, o altro. Possiate voi avere questa libertà.”
(Pubblicato su Il Fatto Quotidiano)
Per soddisfare queste condizioni bisogna sacrificare parecchio e limitarsi a fenomeni piuttosto semplici se paragonati alla complessità della dinamica umana, perché in pratica significa che è necessario controllare le condizioni al contorno di un fenomeno naturale: isolare la causa di ogni fenomeno, valutare ogni effetto singolarmente, ecc. Nel caso delle scienze naturali troviamo inoltre diverse gradazioni: dalla situazione in cui gli esperimenti sono fattibili in laboratorio in diverse condizioni, come in fisica, in chimica, ecc., al caso delle scienze che sono invece principalmente basate sulle osservazioni, come ad esempio la geologia o l’astrofisica. Inoltre, come ci ha insegnato la storia della scienza, non basta costruire, usando la matematica, un’apparente rigore scientifico. Per andare al punto vorrei riproporre l’illuminante lezione magistrale sul senso della scienza e dell’etica scientifica del famoso fisico Richard Feynman:
“Nei mari del Sud vive un popolo che pratica infatti il culto dei cargo: durante la seconda guerra mondiale hanno visto atterrare aerei carichi di ogni ben di Dio, ed ora vorrebbero che la cosa continuasse. Hanno tracciato sul terreno delle specie di piste; accendono fuochi ai loro lati; hanno costruito una capannuccia in cui si siede un uomo con due pezzi di legno a mo’ di cuffie, e da cui sporgono dei bambù a mo’ d’antenne radio (l’uomo rappresenta il controllore di volo); ed aspettano che gli aerei atterrino. Fanno tutto correttamente; la forma è perfetta e rispetta quella originale: ma la cosa non funziona. Non atterra nessun aereo.
Così parlo di scienze da cargo cult: sono scienze che seguono i precetti e le forme apparenti dell’indagine scientifica ma alle quali, però, manca un elemento essenziale, visto che gli aerei non atterrano. A questo punto dovrei indicarvi l’elemento mancante. Sarebbe però altrettanto difficile dello spiegare agli isolani dei mari del Sud come procedere per far funzionare il loro sistema ed arrivare ad un certo benessere. Non si tratta di una cosa semplice, come dir loro di migliorare la forma delle cuffie. Ma c’è soprattutto una cosa che in genere manca nelle scienze da cargo cult: un’idea che tutti ci auguriamo abbiate imparato a scuola; non la esplicitiamo mai, speriamo che la scopriate da soli grazie a tutti gli esempi di indagine scientifica che avete studiato. Ora invece sarà interessante formularla apertamente.
Si tratta dell’integrità scientifica. Un principio del pensiero scientifico che corrisponde essenzialmente ad una totale onestà, ad una disponibilità totale. Per esempio, quando si effettua un esperimento bisogna riferire tutto ciò che potrebbe invalidarlo, e non soltanto quello che sembra in accordo con le aspettative; le altre cause che potrebbero insomma originare gli stessi risultati… (…) …Sappiamo per esperienza che la verità finisce sempre col venire a galla. Altri scienziati ripeteranno il vostro esperimento, e scopriranno se era corretto o no. I fenomeni della natura saranno o no in accordo con la vostra teoria. E magari otterrete una fama temporanea ma, se non avrete lavorato con accuratezza, la vostra reputazione di scienziato non sarà buona. Sono questa integrità, questa volontà di non autoingannarsi, che mancano alla ricerca delle scienze da cargo cult… Vi auguro una cosa sola: la fortuna di trovarvi sempre in una situazione che vi consenta di mantenere liberamente l’integrità di cui ho parlato, e di non sentirvi costretti a perderla per conservare il posto, trovare fondi, o altro. Possiate voi avere questa libertà.”
(Pubblicato su Il Fatto Quotidiano)
venerdì 8 luglio 2011
L’economia è una scienza dura?
L’economia è una scienza falsificabile? Qualche anno fa durante un convegno in cui partecipavano sia fisici che economisti è stato fatto un sondaggio per capire come gli economisti intendono la loro disciplina, con il risultato che metà degli economisti hanno risposto affermativamente a questa domanda mentre l’altra metà negativamente. Situazione curiosa, che sicuramente riflette la spaccatura tra le diverse scuole di pensiero in economia, a cui ho già accennato. La questione non è di lana caprina, e non è puramente accademica. Come ha scritto il mio collega fisico Stefano Zapperi, in un commento ad un dibattito tra Andrea Ichino e il sottoscrittosulla questione dell’aumento delle tasse universitarie, “Affermare che l’economia sia una scienza dura al pari della fisica permette di far passare scelte politiche per risultati scientifici e quindi neutri… Io penso che l’economia tratti di temi che riguardano tutti direttamente, che sono influenzati dai nostri comportamenti e quindi riguardano la politica. La fisica si occupa invece di fenomeni naturali che nella maggior parte dei casi avvengono indipendentemente dalle nostre scelte. Porre l’economia e la fisica sullo stesso piano è sostanzialmente una truffa.”
Quando gli economisti “si sporcano le mani con i dati” (come alcuni dichiarano di fare) siamo sicuri che il risultato alla fine non sia quello di “sporcare i dati con le ideologie”, con quelle ideologie (preconcetti considerati veri a prescindere dall’osservazione empirica) che invece guidano molte delle ricette che sono propinate come soluzioni scientifiche? Certo è che la falsificazione di una teoria scientifica è altra cosa dall’utilizzare alcuni dati opportunamente selezionati o accuratamente manipolati per portare acqua al proprio mulino. A me sembra che si voglia la botte piena e la moglie ubriaca: il prestigio di una scienza dura senza pagare il dazio della falsificabilità, che è la vera e unica chiave di volta d’ogni scienza dura. Queste sono questioni fondamentali che vanno poste perché se non si ammette che la crisi economica ha prodotto una chiara crisi nei modelli economici dominanti, e se sono sempre i soliti, indipendentemente dalla bontà delle loro previsioni, a suggerire scelte cruciali in campo economico (ovvero in qualsiasi campo della vita pubblica) avendo a disposizione l’intero universo mediatico come accade in Italia, con ogni probabilità si continueranno a fare scelte sbagliate che peggioreranno le cose, mascherandole però da scelte dettate da una scienza quantitativa.
Questi sono i motivi, tra gli altri, per cui lo scorso 16 maggio a Londra è stata lanciata una nuova associazione di economisti, che è già diventata una tra le più grandi del mondo e senz’altro la più inclusiva geograficamente, che si propone di essere pluralista, inclusiva e democratica con lo scopo di diffondere il pensiero critico nella rete e introdurre un metodo aperto nella valutazione scientifica: la World Economics Association. Nelle parole di presentazione di Grazia Iettotroviamo di nuovo il tema del ruolo delle ideologie in questa disciplina: “Viviamo in tempi difficili per gli economisti: l’opinione pubblica e i media ci guardano con sospetto, mentre all’interno della professione si nota arroganza, disagio e rabbia. L’arroganza sta dalle parti di quelli che credono che avevano e hanno ragione a propagandare il modello neoclassico e neoliberista d’economia malgrado la crisi (tutt’altro che superata). Per loro è solo questione di tempo; il modello è valido e con il tempo le politiche di tagli, combinate con ritocchi dal lato dell’offerta, porteranno alla ripresa delle economie e il modello di capitalismo dominato dalla finanza (o a trazione finanziaria) continuerà a trionfare. Il disagio è quello di quanti, avendo appoggiato il modello neoclassico, si trovano ora a dover giustificare la loro posizione. C’è rabbia invece tra i molti che non hanno mai aderito al modello neoclassico e neoliberista, compresi i pochi che avevano previsto la crisi sulla base di teorie e modelli alternativi. La loro voce non è stata ascoltata né a livello politico né è stata ospitata sulle pagine delle riviste scientifiche considerate autorevoli e prestigiose.” .
L’anno scorso, l’associazione Paolo Sylos Labini aveva promosso il Manifesto per la libertà del pensiero economico, firmato da centinaia di economisti e persone della cultura di tutto il mondo, con analoghe premesse: “Oggi dopo anni di atrofizzazione si affaccia un nuovo sentire al quale la scienza economica deve saper dare una risposta. La crisi globale in atto segna un punto di svolta epocale. Come in tanti hanno rilevato, oggi entrano in crisi le teorie economiche dominanti e ilfondamentalismo liberista che da esse traeva legittimazione e vigore. Queste teorie non avevano colto la fragilità del regime di accumulazione neoliberista. Esse hanno anzi partecipato alla edificazione di quel regime, favorendo la finanziarizzazione dell’economia, la liberalizzazione dei mercati finanziari, il deterioramento delle tutele e delle condizioni di lavoro, un drastico peggioramento nella distribuzione dei redditi e l’aggravarsi dei problemi di domanda. In tal modo esse hanno contribuito a determinare le condizioni della crisi. E’ necessario ricondurre l’economia ai fondamenti etici che avevano ispirato il pensiero dei classici.”
Altre iniziative sono state intraprese in Francia e in Svizzera. Il dibattito nel campo è dunque molto più aperto ed infuocato di quello che sembra da una lettura dei maggiori quotidiani del nostro paese, che negli ultimi anni, a parte rare eccezioni, hanno subito un ruolo di colonizzazione da parte degli economisti di scuola liberista (qui da noi molti insegnano alla Bocconi). In conseguenza dell’affermarsi di questo pensiero unico, molte scelte cruciali politiche ed economiche sono state influenzate in maniera del tutto trasversale; dei danni causati all’università e alla ricercaabbiamo già ampiamente discusso in questo blog: chiaro esempio del fatto che non si sta parlando del sesso degli angeli, piuttosto di quesiti fondamentali che riguardano tutti e che non possono essere nelle mani di pochi guardiani dell’ideologia.
Quando gli economisti “si sporcano le mani con i dati” (come alcuni dichiarano di fare) siamo sicuri che il risultato alla fine non sia quello di “sporcare i dati con le ideologie”, con quelle ideologie (preconcetti considerati veri a prescindere dall’osservazione empirica) che invece guidano molte delle ricette che sono propinate come soluzioni scientifiche? Certo è che la falsificazione di una teoria scientifica è altra cosa dall’utilizzare alcuni dati opportunamente selezionati o accuratamente manipolati per portare acqua al proprio mulino. A me sembra che si voglia la botte piena e la moglie ubriaca: il prestigio di una scienza dura senza pagare il dazio della falsificabilità, che è la vera e unica chiave di volta d’ogni scienza dura. Queste sono questioni fondamentali che vanno poste perché se non si ammette che la crisi economica ha prodotto una chiara crisi nei modelli economici dominanti, e se sono sempre i soliti, indipendentemente dalla bontà delle loro previsioni, a suggerire scelte cruciali in campo economico (ovvero in qualsiasi campo della vita pubblica) avendo a disposizione l’intero universo mediatico come accade in Italia, con ogni probabilità si continueranno a fare scelte sbagliate che peggioreranno le cose, mascherandole però da scelte dettate da una scienza quantitativa.
Questi sono i motivi, tra gli altri, per cui lo scorso 16 maggio a Londra è stata lanciata una nuova associazione di economisti, che è già diventata una tra le più grandi del mondo e senz’altro la più inclusiva geograficamente, che si propone di essere pluralista, inclusiva e democratica con lo scopo di diffondere il pensiero critico nella rete e introdurre un metodo aperto nella valutazione scientifica: la World Economics Association. Nelle parole di presentazione di Grazia Iettotroviamo di nuovo il tema del ruolo delle ideologie in questa disciplina: “Viviamo in tempi difficili per gli economisti: l’opinione pubblica e i media ci guardano con sospetto, mentre all’interno della professione si nota arroganza, disagio e rabbia. L’arroganza sta dalle parti di quelli che credono che avevano e hanno ragione a propagandare il modello neoclassico e neoliberista d’economia malgrado la crisi (tutt’altro che superata). Per loro è solo questione di tempo; il modello è valido e con il tempo le politiche di tagli, combinate con ritocchi dal lato dell’offerta, porteranno alla ripresa delle economie e il modello di capitalismo dominato dalla finanza (o a trazione finanziaria) continuerà a trionfare. Il disagio è quello di quanti, avendo appoggiato il modello neoclassico, si trovano ora a dover giustificare la loro posizione. C’è rabbia invece tra i molti che non hanno mai aderito al modello neoclassico e neoliberista, compresi i pochi che avevano previsto la crisi sulla base di teorie e modelli alternativi. La loro voce non è stata ascoltata né a livello politico né è stata ospitata sulle pagine delle riviste scientifiche considerate autorevoli e prestigiose.” .
L’anno scorso, l’associazione Paolo Sylos Labini aveva promosso il Manifesto per la libertà del pensiero economico, firmato da centinaia di economisti e persone della cultura di tutto il mondo, con analoghe premesse: “Oggi dopo anni di atrofizzazione si affaccia un nuovo sentire al quale la scienza economica deve saper dare una risposta. La crisi globale in atto segna un punto di svolta epocale. Come in tanti hanno rilevato, oggi entrano in crisi le teorie economiche dominanti e ilfondamentalismo liberista che da esse traeva legittimazione e vigore. Queste teorie non avevano colto la fragilità del regime di accumulazione neoliberista. Esse hanno anzi partecipato alla edificazione di quel regime, favorendo la finanziarizzazione dell’economia, la liberalizzazione dei mercati finanziari, il deterioramento delle tutele e delle condizioni di lavoro, un drastico peggioramento nella distribuzione dei redditi e l’aggravarsi dei problemi di domanda. In tal modo esse hanno contribuito a determinare le condizioni della crisi. E’ necessario ricondurre l’economia ai fondamenti etici che avevano ispirato il pensiero dei classici.”
Altre iniziative sono state intraprese in Francia e in Svizzera. Il dibattito nel campo è dunque molto più aperto ed infuocato di quello che sembra da una lettura dei maggiori quotidiani del nostro paese, che negli ultimi anni, a parte rare eccezioni, hanno subito un ruolo di colonizzazione da parte degli economisti di scuola liberista (qui da noi molti insegnano alla Bocconi). In conseguenza dell’affermarsi di questo pensiero unico, molte scelte cruciali politiche ed economiche sono state influenzate in maniera del tutto trasversale; dei danni causati all’università e alla ricercaabbiamo già ampiamente discusso in questo blog: chiaro esempio del fatto che non si sta parlando del sesso degli angeli, piuttosto di quesiti fondamentali che riguardano tutti e che non possono essere nelle mani di pochi guardiani dell’ideologia.
Iscriviti a:
Commenti (Atom)